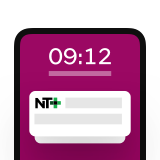La transazione fiscale è subordinata alla condotta pregressa del contribuente e alla sua capacità di attrarre finanza esterna
Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 34/E del 29/12/20
Con la circolare n. 34/E del 29/12/2020 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'istituto della transazione fiscale, nel più ampio quadro giuridico delle procedure di composizione della crisi d'impresa.
La circolare in commento desta ragguardevoli spunti di riflessione circa il ruolo cruciale attribuito alla "condotta fisale" e alla capacità dell'imprenditore di attrarre "finanza esterna" nell'iter di valutazione della qualificazione del credito tributario e accende diversi alert per i contribuenti e i professionisti coinvolti.
La prima considerazione deve riferirsi al fatto che, l'amministrazione finanziaria seppur dichiarando in generale che la condotta fiscale pregressa del contribuente non dovrebbe inficiare o pregiudicare la valutazione della convenienza della proposta di trattamento del credito tributario, dall'altra parte ne afferma la rilevanza nell'iter di valutazione della proposta di transazione fiscale. In particolare, la presenza di condotte pregresse ipotizzabili distrattive o decettive, come le operazioni che possano riferirsi alla simulazione di cessione di un asset aziendale a soggetti correlati; il compimento di atti liberali, come la remissione del debito, non giustificati da normali logiche di mercato, quale potrebbe essere la salvaguardia di specifici rapporti commerciali, il perfezionamento di operazioni di riorganizzazione aziendale, finalizzate a trasferire artatamente nel proprio patrimonio personale dell'imprenditore poste dell'attivo allo scopo di creare una bad company da sottoporre a procedura compositiva, incideranno sul profilo della procedibilità/legittimità della procedura di gestione della crisi di impresa, fino a divenire vere e proprie segnalazioni alle autorità competenti. Così come, i precedenti fiscali del contribuente che possano essere ricondotti ad una sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali; le fattispecie di frode fiscale nelle ipotesi di condotte caratterizzate dall'utilizzo di documentazione falsa, di artifizi e raggiri, operazioni in tutto o in parte simulate che denotano l'assenza da parte del contribuente, di collaborazione e trasparenza nei confronti dell'amministrazione finanziaria, seppur riferendosi ad un lasso di tempo che è antecedente a quello della procedura, devono essere oggetto di valutazione ai fini del trattamento del credito tributario e se necessario, l'amministrazione finanziaria potrà ampliare l'ambito oggettivo di valutazione secondo la gravità dei comportamenti pregressi, fino a ritenere prevalente la tutela delle esigenze erariali rispetto al principio di speditezza della procedura.
La circolare precisa tutte le probabili ipotesi di condotte che per definizione incidono negativamente sull'iter di ammissione al procedimento e il potere di ampliamento dell'ambito oggettivo di valutazione, pur senza individuare le regole di comportamento dell'amministrazione. Verrebbe da pensare che la valutazione dipenda da mere stime dell'accertatore, rilegate al sistema informatico di raccolta e classificazione dei dati fiscali, reddituali e patrimoniali e che l'onere della prova contraria ricada sul contribuente.
Di conseguenza, l'ipotetica condotta pregressa di un‘impresa, che utilizza la leva fiscale tramite il rinvio del pagamento dei debiti tributari e l'utilizzo dello strumento della rateizzazione a favore di un cash flow positivo, potrebbe incidere sul profilo di valutazione della convenienza della proposta di trattamento del credito tributario.
Il tema riveste particolare attenzione perché se da un lato non sono meritevoli di tutela situazioni di sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali suscettibili di mettere in discussione i doveri di costituzionalità in tema di corretto adempimento degli obblighi tributari, occorre dall'altro non di meno valutare se dette violazioni potrebbero rientrare in un quadro più ampio di strategia d'impresa finalizzato a preservare l'equilibrio economico-finanziario.
L'altra considerazione deve riferirsi alla movenza rigorista dell'agenzia delle entrate, laddove afferma il ruolo centrale, in sede di verifica della proposta di transazione fiscale (come di concordato preventivo o di ristrutturazione del debito) della capacità dell'imprenditore di attrarre finanza dei terzi.
La ratio sottostante è che le risorse derivanti da finanza esterna sono indissolubilmente legate alla risoluzione concordata della crisi, involgendo una presunzione relativa di convenienza della proposta di transazione fiscale.
La circolare definisce finanza esterna la disponibilità di risorse finanziarie estranee al patrimonio dell'impresa in stato di crisi- non essendo assoggettabili alla regola della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., né al rigido rispetto delle cause di prelazione di cui all'art. 2741 c.c.- somme che non devono transitare dal patrimonio della società in stato di crisi incrementando l'attivo, ovvero aggravandone il passivo, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo per il rimborso del finanziamento.
L'amministrazione finanziaria chiarisce senza equivoco che, non possono qualificarsi finanza esterna i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale, in quanto hanno la natura di ricavi riconducibili al patrimonio del debitore e pertanto destinati al soddisfacimento dei creditori secondo le regole del concorso, senza alterare l'ordine delle cause di prelazione e che devono garantire il trattamento non deteriore alla pretesa tributaria rispetto ai creditori concorrenti, secondo le prescrizioni le prescrizioni dell'art. 182 ter, primo comma, della legge fallimentare, ed il miglior soddisfacimento rispetto l'alternativa liquidatoria.
In sostanza lo stralcio dei debiti del fisco ed enti previdenziali, per le imprese in crisi non è un percorso senza intralci. Del resto, appare assurdo il ruolo centrale attribuito alla finanza esterna, giacché risulta difficile immaginare la capacità dell'impresa in stato di crisi di attrare risorse da terzi e senza peraltro pesare sullo stato passivo.
__________
*Dottore Commercialista - Revisore Legale
PhD in Scienze Aziendali
Componente del Comitato Scientifico Nazionale Fondazione School University